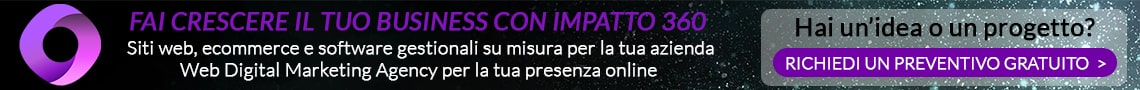Ricordando il secondo Scudetto viola il primo nome che viene alla mente è Giancarlo De Sisti. Perché “Picchio” non era solo il capitano e il regista di quella squadra fantastica, era anche l’uomo capace di guidare i giovani e di far capire loro cosa significasse portare addosso la maglia viola. Oltre che una sorta di allenatore in campo, sul quale il “Petisso” Pesaola non mancava mai di fare affidamento. In una parola era il leader assoluto della mitica Fiorentina yè yè, l’ultima capace di regalare a Firenze l’immensa gioa del Tricolore, di cui oggi celebriamo il cinquantesimo anniversario.
“E’ vero – conferma De Sisti -, io ero un giovane – vecchio, nel senso che pur essendo appena 25enne, ero più maturo rispetto ai ragazzi della mia età, ed ero naturalmente portato ad aiutare i più giovani. Mi piaceva guidarli in campo, insegnare ciò che avevo imparato da campioni come Schiaffino, che avevo avuto come compagno alla Roma, o Hamrin, che era capitano quando arrivai a Firenze. Ma il nostro rapporto non si fermava al campo: spesso invitavo i ragazzi a mangiare a casa mia, dove mia moglie cucinava per tutti. E il lunedì, nel nostro giorno libero, andavamo a giocare a golf all’Ugolino. Ridevamo e ci prendevamo in giro… non troppo però, perché io ero anche un po’ permaloso…”.
Giancarlo De Sisti, ci racconta com’è nata la Fiorentina yè – yè?
“Il progetto lo iniziò Beppe Chiappella. Lui è stato il demiurgo di quel gruppo, colui che ha lanciato i giovani del vivaio e che ci ha dato una preparazione atletica talmente efficace da durare negli anni. Ricordo ancora la fatica su quei gradoni… altro che Zeman! Poi però alla domenica volavamo in campo e nessuno riusciva a starci dietro. Con Chiappella giocò un ruolo determinante anche Egisto Pandolfini. Pensate che fu lui a convincere il presidente Baglini a prendermi dalla Roma e a tirare fuori un bel gruzzoletto per strapparmi ai giallorossi, che non la finivano più di tirare sul prezzo. A un certo punto Baglini se ne voleva andare, ma Pandolfini credeva in me e lo trattenne quasi fisicamente pur di chiudere la trattativa. Comunque quei soldi credo di averli ripagati con gli interessi”.
Pandolfini era anche un formidabile talent scout…
“Eccome, aveva un fiuto eccezionale nel giudicare i giovani e una serie di collaboratori che gli permettevano di battere a tappeto il territorio nazionale per scovare i talenti. I vari Ferrante, Merlo, Esposito, Chiarugi e tanti altri li ha portati lui a Firenze. Ed era pure un gran signore. Ma non voglio nemmeno dimenticare Carlo Montanari e Raffaele Righetti, persone splendide e dirigenti di primissimo livello. Grazie a loro mi sono subito sentito a casa, anche se nel 1965, quando arrivai a Firenze, ero preoccupatissimo perché non ero mai uscito dalla mia Roma. E invece iniziò una storia bellissima”.
Già, la sua storia con Firenze, durata 9 anni e con una seconda avventura da allenatore del quasi Scudetto…
“Firenze è la mia seconda patria, sono stato nove stagioni giocatore, delle quali 7 da capitano. In questa città ho vissuto i momenti più belli della mia vita, ma anche situazioni drammatiche. Come quella dell’alluvione del ‘66. Ricordo ancora che con i compagni di squadra ci tirammo su le maniche per aiutare le persone, facendo il possibile in una città ferita che però dimostrò grande forza e seppe rialzarsi. A Firenze sono stato molto amato e ho amato molto i tifosi. Il presidente Baglini mi portava spesso in giro alle varie cene come se fossi un gioiello. E, devo dire, che rischiai pure di montarmi la testa. Ma non lo feci, anzi ho sempre tenuto i piedi per terra e questo mi ha aiutato a fare la carriera che ho fatto. Poi ho avuto il privilegio di essere l’allenatore della Fiorentina negli anni ‘80. Se avessi se avessi vinto anche quello Scudetto nel 1982 avrei messo in crisi la leadership della popolarità del mio amico Giancarlo Antognoni (ride ndr). Avrei stabilito un record e forse mi avrebbero fatto anche una statua. Scherzi a parte, tutti sanno perché non abbiamo vinto. Ci hanno scippato, ma è inutile rivangare i fantasmi del passato”.
Che ricordi ha di Bruno Pesaola, l’allenatore dello Scudetto?
“E’ stato determinate perché ci ha trasmesso una grandissima autostima. Era un raffinato psicologo che sapeva come tirare fuori il massimo da ognuno di noi. Ci convinse che eravamo i più forti di tutti. A me dava del lei e mi diceva spesso: ‘De Sisti, faccia lei…’ come a dire che non mi doveva insegnare nulla. In realtà mi ha insegnato tanto. Le sue furbizie tattiche mettevano in crisi gli allenatori avversari. E poi era un maniaco della scaramanzia: quella canzone di Peppino Gagliardi era diventata il nostro cavallo di battaglia. Le sue sigarette, il suo cappotto… Era un personaggio unico che ricordo sempre con affetto, anche se qualche volta abbiamo discusso”.
Cosa ha provato quando è stato nominato capitano?
“E’ stata una delle emozioni più forti della mia vita. Ricordo che, nelle prime partite, mi guardavo sempre la fascia, perché mi faceva sentire più bello… un po’ come i calciatori di oggi fanno con i tatuaggi. Devo ringraziare il compianto Pirovano. Fu lui che mi consegnò i gradi di capitano, dicendo che li meritavo per carisma e personalità, oltre che per la posizione che occupavo in campo. Furono i compagni a eleggermi e questo mi dette una grande forza interiore”.
Quando avete capito che potevate vincere davvero lo Scudetto?
“Sembrerà strano, ma lo abbiamo capito dopo la prima e unica sconfitta subita, in casa, col Bologna. Perdemmo malamente e la gente iniziò anche a contestare. Nello spogliatoio ci guardammo tutti negli occhi e fu come una scarica di elettrochoc. Da quel giorno non perdemmo più e, via via che battevamo le grandi del campionato, crescevamo in autostima. Eravamo spensierati, ma non abbiamo mai perso l’equilibrio, tenendo sempre i piedi per terra. Fino a quel pomeriggio dell’11 maggio 1969 che segnò la nostra impresa più bella”.
Si riferisce al giorno di Juventus – Fiorentina?
“Certamente, quel giorno, realizzammo definitivamente il nostro sogno e ci abbandonammo a un’incontenibile euforia. Ricordo come se fosse oggi che il sabato prima della partita, in ritiro a Torino, eravamo tesissimi. Così Pesaola decise di portarci tutti all’ippodromo dove correva il cavallo di Mario Maraschi. Il nostro centravanti amava quel ronzino ed era convinto che avrebbe vinto. Ma le cose andarono diversamente e il suo cavallo “ruppe” subito, finendo squalificato. Grazie a quell’episodio passammo il pomeriggio a ridere, scherzare e a prendere in giro il malcapitato Mario… così la tensione svanì e il giorno dopo facemmo una grande partita. Segnarono Chiarugi e lo stesso Maraschi, la Juve dovette inchinarsi davanti alla nostra superiorità. E così potè cominciare la festa…”.
Festeggiamenti che continuarono anche a Firenze…
“Sì, la festa durò per un’intera settimana per culminare allo stadio nell’ultima col Varese. A Torino ci avevano accompagnato 10mila tifosi. A riceverci a Firenze c’era tutta la città. Lì ci rendemmo conto che eravamo i campioni d’Italia. E a ripensarci, ancora oggi, piango di felicità”.
Una Fiorentina, quella yè yè, molto diversa da quella attuale.
“In effetti pensare che sono passati già 50 anni e che in mezzo secolo non abbiamo più vinto lo Scudetto fa un po’ tristezza. Ma nel calcio di oggi è davvero difficile pensare di replicare quello che già allora fu un miracolo sportivo. Oggi ci sono troppe distanze tra i club medio-piccoli e le big, amplificate da fatturati, sponsor e diritti tv. Ogni anno che passa il gap aumenta. Su questo bisogna essere onesti. Anche se vorrei rivedere la Fiorentina più in alto, almeno in lotta per l’Europa, dove Firenze meriterebbe sempre di stare”.